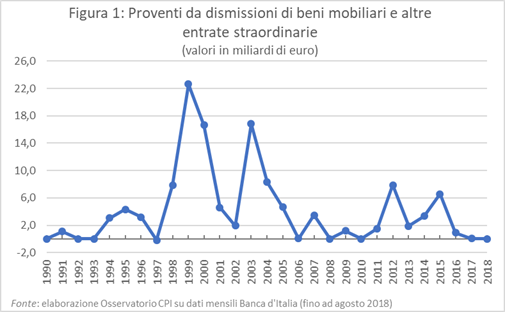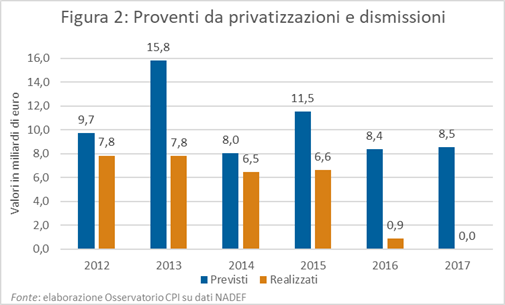|
L’idea di dismettere il patrimonio immobiliare dello Stato attraverso operazioni di cartolarizzazione ha come scopo quello di consentire la conversione di immobili di proprietà pubblica in strumenti finanziari più liquidi e facilmente collocabili sui mercati. Lo schema su cui si basa questa idea coinvolge tre soggetti principali: gli enti pubblici cedenti, una società di cartolarizzazione (c.d. “società-veicolo”) appositamente creata e gli investitori privati. In sostanza, gli enti cedenti trasferiscono il proprio portafoglio di immobili ad un’entità esterna, la società di cartolarizzazione, che si occupa della loro gestione e vendita. L’incasso che lo Stato riceve dalla società di cartolarizzazione è costituito da due componenti: il “prezzo iniziale”, cioè l’ammontare che la società raccoglie sul mercato tramite l’emissione e la collocazione di titoli obbligazionari presso investitori privati, e l’eventuale “prezzo differito”, cioè la liquidità finale residua della società, derivante dalla vendita degli immobili al netto del rimborso dei titoli, del pagamento degli interessi e di altri costi accessori.
All’inizio degli anni duemila, su iniziativa dell’allora Ministro Tremonti, il nostro paese è stato protagonista di due operazioni di cartolarizzazione, gestite dalla neo-costituita SCIP s.r.l. (Società Cartolarizzazione Immobili Pubblici). La prima operazione, denominata “SCIP1”, è partita nel novembre 2001 con il trasferimento alla società di cartolarizzazione di 27.250 immobili residenziali e 262 immobili commerciali di proprietà di sette enti previdenziali pubblici, per un valore di mercato complessivo stimato in circa 5,1 miliardi di euro. Per calcolare il valore effettivo di vendita di tali beni si deve però considerare che per gli immobili residenziali la legge prevedeva la concessione di uno sconto del 30% agli inquilini (più un ulteriore 15% in caso di acquisto dell’intero edificio): il valore di offerta in vendita era quindi pari a circa 3,8 miliardi di euro. L’importo (“prezzo iniziale”) incassato dallo Stato è risultato pari a 2,3 miliardi di euro e il buon andamento dei ricavi di vendita ha consentito a SCIP di rispettare le tempistiche previste e completare nel dicembre 2003 il rimborso integrale dei titoli emessi. Il risultato finale è stato positivo: alla vigilia della liquidazione della società (1 marzo 2009), il saldo del conto corrente di tesoreria, al netto delle spese sostenute, risultava pari a circa 1,4 miliardi di euro. Tuttavia, l’esito complessivo di questa prima operazione è dovuto in gran parte al fatto che gli immobili coinvolti in SCIP1 erano già stati inseriti in due precedenti programmi di dismissione (POC-Programma Ordinario di Cessione, varato nel 1999; PSC-Programma Straordinario di Cessione, varato nel 1997) e hanno potuto quindi beneficiare di attività propedeutiche alla vendita già svolte.
L’operazione “SCIP2” è stata avviata nel dicembre 2002 con la cessione da parte degli stessi enti previdenziali pubblici e dello Stato di 53.241 immobili residenziali e 9.639 immobili commerciali, per un valore di offerta pari a circa 7,8 miliardi di euro (valore di mercato di circa 11,1 miliardi a cui sottrarre gli sconti per gli inquilini). A fronte della cessione degli immobili, SCIP ha corrisposto ai soggetti cedenti un “prezzo iniziale” di circa 6,6 miliardi di euro, corrispondenti al ricavo di cinque emissioni di titoli. È opportuno evidenziare che l’operazione SCIP2, a differenza di SCIP1, è stata realizzata su immobili per i quali le attività propedeutiche alla vendita dovevano essere ancora avviate. Anche per questo motivo l’operazione ha incontrato fin da subito una serie di complicazioni legate ad un rallentamento delle vendite, che hanno reso necessaria la ristrutturazione del debito di SCIP2, effettuata nel mese di aprile 2005 con l’emissione di tre nuove serie di titoli per un ammontare complessivo di 4,4 miliardi di euro. Le difficoltà a generare i flussi di cassa previsti sono però rimaste anche dopo la ristrutturazione del debito, al punto che la legge 14/2009 ha previsto, a partire dal 1 marzo 2009, la liquidazione delle due operazioni e il trasferimento ai soggetti originariamente proprietari degli immobili non ancora venduti. Il fallimento di SCIP2 è evidente se si guardano i dati di bilancio a fine febbraio 2009: delle 62.880 unità immobiliari coinvolte nell’operazione, 24.823 risultavano invendute, per un valore pari a circa 2,2 miliardi di euro.[1] In aggiunta, il versamento a copertura delle passività di SCIP2, al netto delle disponibilità liquide, è costato allo Stato oltre 1,7 miliardi di euro, andando così ad intaccare il prezzo iniziale e determinando un incasso complessivo pari a soli 4,9 miliardi di euro. A questa cifra andrebbero poi sottratti alcuni costi di minore entità (ad es. le spese per la cartolarizzazione e il collocamento dei titoli o quelle relative al funzionamento corrente di SCIP), ma i dati consuntivi in merito non sono mai stati pubblicati.
Tavola 1: Sintesi delle operazioni SCIP1 e SCIP2
|
|
Tempistiche rimborsi
|
N° immobili coinvolti
|
Valore di mercato
|
Valore di offerta
|
Prezzo iniziale
|
Liquidità finale
|
|
SCIP1
|
2001-2003
|
27.512
|
5,1 miliardi
|
3,8 miliardi
|
2,3 miliardi
|
1,4 miliardi
|
|
SCIP2
|
2002-2009
|
62.880
|
11,1 miliardi
|
7,8 miliardi
|
6,6 miliardi
|
-1,7 miliardi
|
Fonte: Relazione al Parlamento sulle operazioni di cartolarizzazione dei proventi derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, primo semestre 2009; Relazione del Servizio Studi della Camera sulle cartolarizzazioni di immobili pubblici.
|